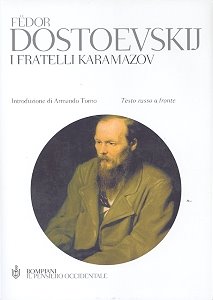Sembra una storia come tante altre quella di Bartolomeo – piemontese – e Nicola – pugliese. All’inizio del Novecento decisero di lasciare l’Italia alla volta di quella che, allora, era la terra promessa: l’America. Per raggiungerla i due giovani italiani – il primo pescivendolo e il secondo calzolaio – fecero un lungo viaggio. Sbarcarono a 17 anni nella Boston del 1908, senza conoscersi, senza neppure sapere perché ci fossero andati. Erano soltanto due "dego", come chiamavano con disprezzo gli italiani, due immigrati senza permesso, due extra-americani andati a inquinare con le loro abitudini, la loro religione e le loro idee pericolose una grande nazione. "Dove potevo andare? Cosa potevo fare?" scriveva Vanzetti. "Quella era la Terra promessa. Il treno della sopraelevata passava sferragliando e non rispondeva niente. Le automobili e i tram passavano oltre senza badare a me." Sicché lui e Sacco, ciascuno per conto proprio, dovettero cominciar subito a questuare un lavoro qualsiasi, a qualsiasi paga - per non crepare di fame. Sacco, che in Italia aveva fatto il calzolaio, trovò un posto in una fabbrica di calzature a Milford (Massachusetts). Si sposò e andò a stare in una casa con giardino. Ebbe un figlio, Dante, e una figlia, Ines. Lavorava sei giorni la settimana, dieci ore al giorno. Trovava anche il tempo per prendere parte a dimostrazioni indette da operai che chiedevano un salario più alto e condizioni di lavoro più umane e così via; per tali cause teneva discorsi e dava contributi in denaro. Fu arrestato, a causa di tali attività, nel 1916. Vanzetti non aveva un mestiere e quindi lavorava qua e là: in trattorie, in una cava, in un'acciaieria, in una fabbrica di cordami. Era un avido studioso e lesse Marx, Darwin, Hugo, Gor'kij, Tolstoj, Zola e Dante. Nel 1916 guidò uno sciopero contro la fabbrica di cordami, la “Plymouth Cordage Company”. Era sulle liste nere dei datori di lavoro, sicché per sopravvivere si mise a fare il pescivendolo per conto proprio. In quell’anno Sacco e Vanzetti si conobbero a fondo. Entrambi contestavano la brutalità del padronato, secondo il quale pochi sovrintendenti controllavano lo spreco di milioni di vite, nella speranza di far soldi. Era chiaro per loro, anche, che l'America sarebbe presto intervenuta. Non volevano esser costretti a lavorare in siffatte fabbriche in Europa, quindi si unirono a un gruppo di anarchici italo-americani. Il 5 maggio 1920 Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti vengono arrestati, perché nei loro cappotti nascondevano armi e volantini inneggianti all’anarchia. Dopo tre giorni sono accusati dell'omicidio di una guardia giurata e di un cassiere durante la rapina di South Braintree, un sobborgo di Boston. I due hanno un alibi di ferro, prove testimoniali a loro favore e addirittura la confessione del vero assassino, un detenuto accusato di un altro omicidio: eppure non c'è niente da fare, sono giudicati colpevoli. Il mondo intero si mobilita, nascono comitati per la liberazione degli innocenti, arrivano appelli dall'Italia. Nulla da fare. Sacco e Vanzetti furono condannati alla sedia elettrica.
Sembra una storia come tante altre quella di Bartolomeo – piemontese – e Nicola – pugliese. All’inizio del Novecento decisero di lasciare l’Italia alla volta di quella che, allora, era la terra promessa: l’America. Per raggiungerla i due giovani italiani – il primo pescivendolo e il secondo calzolaio – fecero un lungo viaggio. Sbarcarono a 17 anni nella Boston del 1908, senza conoscersi, senza neppure sapere perché ci fossero andati. Erano soltanto due "dego", come chiamavano con disprezzo gli italiani, due immigrati senza permesso, due extra-americani andati a inquinare con le loro abitudini, la loro religione e le loro idee pericolose una grande nazione. "Dove potevo andare? Cosa potevo fare?" scriveva Vanzetti. "Quella era la Terra promessa. Il treno della sopraelevata passava sferragliando e non rispondeva niente. Le automobili e i tram passavano oltre senza badare a me." Sicché lui e Sacco, ciascuno per conto proprio, dovettero cominciar subito a questuare un lavoro qualsiasi, a qualsiasi paga - per non crepare di fame. Sacco, che in Italia aveva fatto il calzolaio, trovò un posto in una fabbrica di calzature a Milford (Massachusetts). Si sposò e andò a stare in una casa con giardino. Ebbe un figlio, Dante, e una figlia, Ines. Lavorava sei giorni la settimana, dieci ore al giorno. Trovava anche il tempo per prendere parte a dimostrazioni indette da operai che chiedevano un salario più alto e condizioni di lavoro più umane e così via; per tali cause teneva discorsi e dava contributi in denaro. Fu arrestato, a causa di tali attività, nel 1916. Vanzetti non aveva un mestiere e quindi lavorava qua e là: in trattorie, in una cava, in un'acciaieria, in una fabbrica di cordami. Era un avido studioso e lesse Marx, Darwin, Hugo, Gor'kij, Tolstoj, Zola e Dante. Nel 1916 guidò uno sciopero contro la fabbrica di cordami, la “Plymouth Cordage Company”. Era sulle liste nere dei datori di lavoro, sicché per sopravvivere si mise a fare il pescivendolo per conto proprio. In quell’anno Sacco e Vanzetti si conobbero a fondo. Entrambi contestavano la brutalità del padronato, secondo il quale pochi sovrintendenti controllavano lo spreco di milioni di vite, nella speranza di far soldi. Era chiaro per loro, anche, che l'America sarebbe presto intervenuta. Non volevano esser costretti a lavorare in siffatte fabbriche in Europa, quindi si unirono a un gruppo di anarchici italo-americani. Il 5 maggio 1920 Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti vengono arrestati, perché nei loro cappotti nascondevano armi e volantini inneggianti all’anarchia. Dopo tre giorni sono accusati dell'omicidio di una guardia giurata e di un cassiere durante la rapina di South Braintree, un sobborgo di Boston. I due hanno un alibi di ferro, prove testimoniali a loro favore e addirittura la confessione del vero assassino, un detenuto accusato di un altro omicidio: eppure non c'è niente da fare, sono giudicati colpevoli. Il mondo intero si mobilita, nascono comitati per la liberazione degli innocenti, arrivano appelli dall'Italia. Nulla da fare. Sacco e Vanzetti furono condannati alla sedia elettrica. Il colpevole era un famigerato ladro e assassino a nome Celestino Madeiros, condannato per un altro delitto. All’approssimarsi della fine, Madeiros confessò di esser lui l'autore degli omicidi per cui Sacco e Vanzetti erano stati condannati a morte. Perché? "Ho visto la moglie di Sacco venirlo a trovare coi figli, e mi hanno fatto pena, quei figlioli" disse. […]Per secondo toccò a Sacco. Dei tre, era l'unico che avesse famiglia. L'attore chiamato a interpretarlo dovrà dar vita a un uomo molto intelligente che, non essendo ben padrone dell'inglese, né molto bravo a esprimersi, non poteva fidarsi di dire alcunché di complicato ai testimoni, mentre lo assicuravano alla sedia elettrica."Viva l'anarchia" disse. "Addio, moglie mia, figli miei, e tutti i miei amici" disse. "Buonasera, signori" disse poi. "Addio, mamma" disse. Era un calzolaio, costui. Le luci della prigione si abbassarono tre volte. Per ultimo toccò a Vanzetti. Si sedette da sé sulla sedia, dove già erano morti Madeiros e Sacco, prima che gliel'ordinassero. Cominciò a parlare ai testimoni prima che gli dicessero che era libero di farlo. Anche per lui l'inglese era la seconda lingua, ma ne era padrone. Ascoltate: "Desidero dirvi," disse, "che sono innocente. Non ho commesso nessun delitto, ma qualche volta dei peccati, sì. Sono innocente di qualsiasi delitto, non solo di questo, ma di ogni delitto. Sono innocente". Faceva il pescivendolo, al momento dell'arresto. "Desidero perdonare alcune persone per quello che mi hanno fatto" disse. Le luci della prigione si abbassarono tre volte.
Riprendere tra le mani le immagini di quei due giovani emigranti – spinti dalla speranza di poter vivere in un mondo migliore – non significa fare un viaggio nel passato dell'America, ma nel presente di tutti. Significa rivivere, nella Boston del 1921, pagine di cronaca già viste in merito all’emergenza immigrati che incessantemente coinvolge il nostro Paese. Significa avere un’occasione in più per riflettere sull’ingiustizia, sui pregiudizi e su chi davvero eravamo. Non ci sono molte differenze tra i migranti di allora e quelli odierni. "I centri di accoglienza degli immigrati di allora ricordano molto quelli di oggi in Italia" pronunciò Fabrizio Costa, regista di una recente fiction sui due anarchici; questo è solo un esempio che ci fa capire, ancora una volta, cosa vivono gli immigrati attuali quando arrivano in Italia. Quella di Sacco e Vanzetti è una storia che può ripetersi anche oggi: solo che noi italiani, questa volta, stiamo dall’altra parte della barricata.