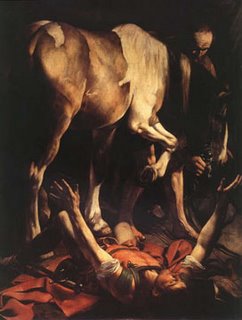L'essere del guerriero – potremmo dire con il filosofo tedesco Martin Heidegger – è un essere-per-la-morte. Ma non bisogna lasciarsi ingannare. Vivere in funzione della propria inevitabile quanto ineluttabile fine, non vuol dire diventare schiavi di questo pensiero fisso – che ci assilla con il suo truce sentore, ad ogni istante della nostra incerta esistenza. All'opposto, vivere con la consapevolezza di dover-morire significa liberarsi da questo pensiero intollerabile. Lo stesso Heidegger distingue due categorie di pensiero: la paura da un lato e l'angoscia dall'altro. Se la prima è diretta verso qualcosa di determinato, ovvero si ha paura di qualcosa di preciso – di una malattia o di una qualsiasi altra catastrofe –, diversamente la seconda è diretta verso qualcosa di indeterminato, ovvero si prova angoscia per la propria condizione di finitezza umana – sapendo che, prima o poi, si dovrà morire. Mentre l'una ha degli effetti palesi – la paura è un sentimento che si manifesta potentemente –, l'altra s'insidia negli abissi insondabili dell'animo umano – l'angoscia è un serpente silenzioso, che ci striscia dentro e ci inietta il suo veleno mortifero che, a poco a poco, farà il suo lento corso fino ad avvelenare l'intera nostra esistenza. I samurai, guerrieri del medioevo giapponese, escogitarono un rimedio efficace per sputare fuori questo veleno esistenziale. Essi vivevano ogni secondo immaginando di morire in mille maniere differenti: trafitti da un colpo ferale di katana, infilzati da una freccia in mezzo alla mischia, accoltellati durante una rissa in taverna, eccetera1. L'essenza di questa loro etica è contenuta in nuce nell'Hagakure – Il Codice Segreto dei Samurai. Libro misterioso del monaco buddista – ex samurai – Yamamoto Tsunetomo, che lo voleva destinare alle fiamme e che è stato invece salvato dall'oblio da un suo discepolo disubbidiente (Tashiro Tsuramoto). Ad una prima lettura, questa pietra miliare della saggezza giapponese si presenta come un testo ricco di aneddoti, di ricordi e di citazioni disarticolate; in un secondo momento si rivela essere la Repubblica platonica dei samurai – per usare un degno paragone appartenente al nostro immaginario occidentale.
L'essere del guerriero – potremmo dire con il filosofo tedesco Martin Heidegger – è un essere-per-la-morte. Ma non bisogna lasciarsi ingannare. Vivere in funzione della propria inevitabile quanto ineluttabile fine, non vuol dire diventare schiavi di questo pensiero fisso – che ci assilla con il suo truce sentore, ad ogni istante della nostra incerta esistenza. All'opposto, vivere con la consapevolezza di dover-morire significa liberarsi da questo pensiero intollerabile. Lo stesso Heidegger distingue due categorie di pensiero: la paura da un lato e l'angoscia dall'altro. Se la prima è diretta verso qualcosa di determinato, ovvero si ha paura di qualcosa di preciso – di una malattia o di una qualsiasi altra catastrofe –, diversamente la seconda è diretta verso qualcosa di indeterminato, ovvero si prova angoscia per la propria condizione di finitezza umana – sapendo che, prima o poi, si dovrà morire. Mentre l'una ha degli effetti palesi – la paura è un sentimento che si manifesta potentemente –, l'altra s'insidia negli abissi insondabili dell'animo umano – l'angoscia è un serpente silenzioso, che ci striscia dentro e ci inietta il suo veleno mortifero che, a poco a poco, farà il suo lento corso fino ad avvelenare l'intera nostra esistenza. I samurai, guerrieri del medioevo giapponese, escogitarono un rimedio efficace per sputare fuori questo veleno esistenziale. Essi vivevano ogni secondo immaginando di morire in mille maniere differenti: trafitti da un colpo ferale di katana, infilzati da una freccia in mezzo alla mischia, accoltellati durante una rissa in taverna, eccetera1. L'essenza di questa loro etica è contenuta in nuce nell'Hagakure – Il Codice Segreto dei Samurai. Libro misterioso del monaco buddista – ex samurai – Yamamoto Tsunetomo, che lo voleva destinare alle fiamme e che è stato invece salvato dall'oblio da un suo discepolo disubbidiente (Tashiro Tsuramoto). Ad una prima lettura, questa pietra miliare della saggezza giapponese si presenta come un testo ricco di aneddoti, di ricordi e di citazioni disarticolate; in un secondo momento si rivela essere la Repubblica platonica dei samurai – per usare un degno paragone appartenente al nostro immaginario occidentale.Già la parola stessa “samurai” potrebbe bastarci per comprendere la semplice ma profonda mentalità di questi romantici guerrieri giapponesi – che paiono collocarsi fuori da ogni epoca storica e da ogni contesto specifico. Essa designa l'atto del servire un padrone. E in questo coscienzioso servizio, precisamente, si esauriva ogni loro compito. Chi crede che oggi in Giappone la mentalità del samurai non esista più, si sbaglia. Il fenomeno della “samuraizzazione” ha contagiato ogni singolo strato della società nipponica ed ora sopravvive nell'etica lavorativa dell'impiegato giapponese, il quale lavora con grande attaccamento e dedizione alla propria azienda. Al posto del padrone da servire, l'impiegato medio nipponico di oggi si ritrova a servire il proprio datore di lavoro. Questo sistema gerarchico, quanto meno eccessivo per noi osservatori occidentali, è alla base del processo d'industrializzazione accelerato che ha riportato la patria del Sol Levante al posto di tutto rispetto che più gli spetta fra il lotto delle super-potenze mondiali.
Lo spettacolare harakiri – modo in cui i samurai, sventrandosi, si davano la morte – dello scrittore nipponico Yukio Mishima2, avvenuto in diretta televisiva il 25 novembre del 1970, riportò in auge l'Hagakure – testo basilare della cultura giapponese posto all'indice dagli americani, usciti vincitori dalla Seconda guerra mondiale e che riconobbero proprio in esso una sorta di Bibbia nichilista, che aveva spinto il fiore della gioventù nipponica ad arruolarsi fra le fila dei kamikaze, i quali andavano a sfracellarsi a bordo dei loro aerei sulle navi da guerra americane per servire la loro patria e il loro imperatore. Certo il comandamento «la Via del Samurai è la morte» si prestò molto bene al fraintendimento degli yankees, che da occidentali non capirono affatto l'autentico significato di questo insegnamento – che invitava ad accettare la morte per vivere appieno la vita e fugare così ogni paura vana.
L'unico insegnamento che in Occidente potrebbe venire – seppur lontanamente – paragonato a quello appena citato e tratto dall'Hagakure, lo impartì Epicuro. Costui invitò a non temere la morte, in quanto riconosceva in essa qualcosa di totalmente assente dalla realtà stessa della vita, dato che – estrapolando il succo del suo pensiero – quando c'è la vita non c'è la morte e quando c'è la morte non c'è la vita! In Occidente, patria della filosofia, si contano infatti sul palmo di una mano le rare eccezioni di autori – sia antichi che moderni – che potrebbero venire ricondotti ad una certa saggezza tipicamente orientale. Si tratta dei già citati Heidegger ed Epicuro, a cui si aggiungono Nietzsche, Schopenhauer e l'illustre Socrate, il più sapiente fra gli uomini secondo la nota profezia dell'Oracolo di Delfi. In un passo riportato da Platone, ne L'apologia di Socrate, lo stesso cittadino esemplare ateniese, dopo esser stato processato e condannato a morte per empietà3, afferma: «Ma ecco che è l’ora di andare: io a morire, e voi a vivere. Chi di noi due vada verso il meglio è oscuro a tutti, fuori che a Dio».4
Nel pensiero di Socrate, fondatore della filosofia occidentale, era già contenuto – come traspare inequivocabilmente dalla citazione sopra riportata – il germe del nichilismo. Difatti il suo dubitare che la morte fosse tanto peggio della vita, cos'è se non il più antico esempio di nichilismo di cui ci è giunta memoria? La supremazia della vita sulla morte qui viene tenacemente rigettata da Socrate, che sembra addirittura augurarsi quest'ultima come il minore dei mali. Certo questa sua massima potrebbe venire interpretata basandosi sul contesto da cui è scaturita, ovvero: quale ultima volontà di un condannato a morte, che sta per assaporare il calice amaro della cicuta. Sia quel che sia, riflettendo attentamente, che cos'è in fondo la filosofia se non la cristallizzazione della vita? Del resto la filosofia, direttamente o indirettamente, ha comunque a che fare con la morte; potremmo dire che essa sia uno strumento di consolazione alternativo alla religione. E niente lo testimonia meglio dell'aforisma sopra riportato di Socrate. Il modo in cui lui va incontro alla sua inesorabile sorte, ci ricorda la saggezza degli indiani d’America. Quando si approssimava la loro ultima ora, essi erano soliti prendere congedo dai loro cari senza tante smancerie, togliendo il disturbo da questa vita quasi in punta di piedi – oseremmo dire. Analogo è senza dubbio il caso dei samurai, i quali, con lo stesso senso dell'ignoto presente in Socrate, solevano andare in battaglia, dove si dimostravano impavidi perché si erano liberati della spada di Damocle che era calata sopra le loro teste quale: la Morte appunto.
Proprio il pensiero della morte, invece che appesantire l'esistenza dei samurai, la rendeva più lieve e sopportabile5. Il loro spirito alleggerito li rendeva dei guerrieri formidabili. Solo con uno spirito del tutto rinnovato, come quello dei samurai, si possono affrontare trionfalmente le mille e più battaglie che la vita ci pone davanti ogni giorno. Il samurai, munito del suo inseparabile spirito guerriero, queste battaglie sapeva affrontarle con coraggio impareggiabile e come nessun altro seppe mai fare, consapevole che solo nell'ora più estrema si può misurare l'effettivo valore di un uomo. In definitiva l'etica del samurai può venire così riassunta: chi ha paura di morire, ha paura anche di vivere... Morte e Vita sono perciò il rovescio della stessa medaglia, pertanto: non saper accettare l'una significherebbe non saper accettare neppure l'altra!
Di ciò i samurai erano consapevoli. Questa loro semplice, ma pressoché indubitabile, consapevolezza li fece elevare al di sopra dei loro simili. Solo sconfiggendo le proprie paure ci si potrà liberare, infatti, dal dominio della morte e dirsi veramente degli uomini liberi. Per far ciò occorre, però, prima capire a fondo la Via del Guerriero che è: l'essere-per-la-morte heideggeriano. Per dirlo con il sommo maestro Yamamoto Tsunetomo: «Io ho scoperto che la via del samurai è morire. Davanti all'alternativa della vita e della morte è preferibile scegliere la morte. Non c'è bisogno di pensarci; presa la decisione si va avanti. Morire senza aver raggiunto lo scopo è una morte da cani e un Bushido6 da mercanti [...] Questa è l'essenza del Bushido: pensando alla morte, mattina e sera, nel silenzio e stando pronti a morire ad ogni momento, si assimila il Bushido e per tutta la vita, senza commettere errori, si adempie il dovere del samurai»7. Solo chi, come il samurai, sarà capace di morire infinite volte, saprà rinascere alla vera vita del guerriero. E scopo del guerriero è appunto quello di vivere e, soprattutto, morire con onore.
1 Vale la pena riportare per intero questo mirabile aforisma: «La meditazione sulla certezza della morte deve essere praticata tutti i giorni. Ogni mattina in profondo raccoglimento del corpo e della mente, devi immaginarti di venire fatto a pezzi da frecce, fucilate, lance e spade, oppure di venire travolto dalle onde, di trovarti in mezzo a un vasto incendio, di venire colpito da un fulmine, di venire scosso da un grande terremoto, di cadere in un profondo precipizio, di morire di malattia e infine di dover fare harakiri per la morte del tuo signore. Ogni mattina, senza alcuna negligenza, devi considerarti come morto.». Tsunetomo, Y., Hagakure – Il Codice Segreto dei Samurai, Einaudi, Torino, 2001, cit. p. 184.
2 L'opera di questo autore è tutta pervasa da una dura critica al processo sfrenato di modernizzazione del suo Paese, dimentico di quei valori originari e tradizionali che lo avevano reso grande in passato.
3 La pena prevista nell'antica Atene per questo reato era l'esilio, ma a Socrate gli venne commutata in pena capitale, visto che si era rifiutato di abbandonare la propria polis, per non infrangere quelle leggi in virtù delle quali lui si era sempre battuto. Per l'incredibile dedizione dimostrata per la sua patria, al servizio della quale lui si immolò, Socrate potrebbe dirsi il “Primo Samurai” di cui ci è giunta l'eco. D'altronde, la filosofia stessa di Socrate serve ad uno scopo terapeutico, ossia: preparare alla morte...
4 Platone, Apologia di Socrate – Critone, a cura di M. Valgimigli, Laterza, Roma-Bari, 2000, cit. p. 65.
5 L'essenza della vita per un samurai si riassume in questo folgorante aforisma del monaco Tannen: «L'insegnare soltanto il vuoto mentale non è una cosa convincente. Il non pensare significa pensare rettamente». Tsunetomo, Y., Hagakure – Il Codice Segreto dei Samurai, Einaudi, Torino, 2001, cit. p. 23.
6 Il Bushido è «la Via del Samurai».
7 Tsunetomo, Y., Hagakure – Il Codice Segreto dei Samurai, Einaudi, Torino, 2001, cit. pp. 11-12.

 L'elemento che hanno in comune le società umane è il sacrificio fondativo
L'elemento che hanno in comune le società umane è il sacrificio fondativo